John Muir
di Paola Mazzarelli
(pubblicato su Alp n. 127, novembre 1995)
«Il babbo permise che [mio fratello] David mi accompagnasse a Pardeeville, luogo che non avevo mai visto, benché si trovasse solo nove miglia a sud di Hickory Hill, la nostra fattoria. Quando arrivammo alla locanda, il paese aveva l’aria di un luogo deserto. Non c’era anima viva in giro. Posai l’involto sull’impiantito traballante della veranda. David mi augurò buona fortuna e ripartì, lasciandomi solo nel mondo. Attirato dal cigolio delle ruote del carro che invertiva marcia, l’oste uscì fuori. Notò subito il fagotto. Mi guardò e disse: – Salute, giovanotto. Che hai lì? – Macchine – risposi – per misurare il tempo.
– Oh, beh! Che stranezza. Devi essere uno di quegli Yankee dell’Est. Dove le hai prese?
– Nella mia testa.
Due o tre persone che passavano in fondo alla strada notarono che l’oste osservava qualcosa con curiosità e vennero a vedere di che si trattava. In un posto come Pardeeville un gruppetto di tre o quattro è una folla: un quarto d’ora dopo l’intera popolazione del paese faceva cerchio attorno ai miei marchingegni di legno».
E l’anno 1860. Siamo nel cuore del Wisconsin, terra di pionieri. I “marchingegni” che il giovanotto intende esporre alla fiera di Madison nella speranza che lo aiutino a trovare un lavoro “per qualche tempo in mezzo alle macchine”, in fabbrica o in officina, diventano un’attrazione cittadina. Tutti i giornali locali ne parlano e Daniel Muir, dalla fattoria di Hickory Hill, scrive al figlio una lettera sul peccato della vanità. «Quando dissi a mio padre che intendevo andarmene di casa e gli chiesi se, trovandomi a corto di denaro, avrei potuto contare sul suo aiuto, rispose: – No, conta solo su te stesso». Così comincia il viaggio alla ventura del ventiduenne John Muir: ha in tasca una decina di dollari guadagnati vendendo il grano che ha coltivato di straforo in un pezzo di terreno incolto e una moneta d’oro che gli ha regalato il nonno undici anni prima, quando la famiglia dalla nativa Scozia è emigrata in America. Era il 1849, l’anno della febbre dell’oro; ma Daniel Muir lasciava Dunbar e il commercio di granaglie attirato dalla promessa della terra: la sterminata, fertile terra vergine d’America, in attesa solo di braccia buone a lavorarla, che fu il sogno di intere generazioni di emigranti dell’Ottocento.
Daniel Muir aveva le sue braccia e quelle dei figli (tre maschi, il maggiore dei quali, John, aveva undici anni, e quattro ragazze), ma poca esperienza: in pochi anni esaurì la terra e la famiglia fu costretta a spostarsi più in là, ricominciando da capo ad abbattere alberi, dissodare il terreno, seminare, per ritagliarsi una fonte di sopravvivenza dalla wilderness. A Hickory Hill non c’era acqua in superficie: toccò a John scavare – a mano, con martello e scalpello – un pozzo profondo una trentina di metri, fino a trovare la falda. Giudicata con criteri moderni, la vita nella fattoria di Hickory Hill è durissima: si lavora tutti i giorni, dall’alba al tramonto, estate e inverno. Giornate anche di sedici, diciassette ore. Due giorni di vacanza all’anno, il 4 luglio e il primo gennaio. Orari inflessibili: ci si alza alle cinque, si va a letto dopo le preghiere della sera, un’ora di intervallo a pranzo. «Mio padre mise ogni cura nell’insegnarci a considerare noi stessi miseri vermi della terra, concepiti nel peccato; e devotamente credeva che soffocare ogni scintilla d’orgoglio e di fiducia in se stessi fosse sacro dovere…».
Il rigido calvinismo paterno non lascia spazio allo svago, né tanto meno all’ozio. La Bibbia è lettura doverosa, la matematica è tollerata, i romanzi banditi. John, cui viene proibito di restare alzato la sera, legge a spizzichi tutto quello su cui riesce a mettere le mani, dieci minuti ora, cinque minuti poi; ogni attimo, un lusso. Dal giorno in cui ottiene il permesso di alzarsi all’ora che vuole, si sveglia tutte le notti all’una: quattro ore intere per sé, quando il resto della casa è immersa nel sonno. Quattro ore che all’adolescente paiono un tempo lunghissimo e prezioso: le passa nel seminterrato, leggendo gli autori proibiti presi in prestito da vicini condiscendenti, studiando fisica e chimica e inventando le “macchine” che susciteranno la disapprovazione diffidente del genitore, l’ammirazione incondizionata delle sorelle e la meraviglia dei visitatori della fiera di Madison: serrature automatiche per chiudere le porte, termometri così sensibili da registrare l’avvicinarsi di una persona, igrometri, orologi, un aggeggio per dar da mangiare ai cavalli all’ora stabilita, un accendi-lampada automatico, un accendi-fuoco automatico, la “macchina per alzarsi presto”, che butta giù dal letto i dormiglioni.
A Madison il giovane contadino campa di lavoretti e di invenzioni. Essere ammesso all’università è il suo sogno. Non ha curriculum di studi regolare, perché dall’epoca della Scozia non ha più messo piede in una scuola, ma forse neppure gli altri studenti ce l’hanno: il Wisconsin è ancora terra di frontiera, la gente va e viene, il mito del self made man, l’uomo che si fa da sé, che gli intellettuali dell’Est si affannano a costruire e giustificare nelle pagine dei libri, qui è realtà di fatto, esperienza di ognuno. Quando scopre che può pagarsi la retta, magari sopravvivendo a pane e latte per mesi, Muir si iscrive: studia chimica, matematica e fisica, greco e latino, botanica e geologia, e ogni altra scienza che suscita il suo interesse. La sua stanza diventa presto meta di pellegrinaggio per studenti e professori: nessuno ha mai visto una scrivania come quella che il nuovo studente si è costruita. «Nelle buie mattine d’inverno, come il letto mi dava la sveglia, si accendeva la luce. Poi, trascorsi i minuti necessari a vestirsi, si udiva un click e dallo scaffale sotto il piano della scrivania usciva il primo libro della giornata, che si apriva e restava sul tavolo il tempo stabilito. Poi il meccanismo richiudeva il libro e lo faceva ricadere al suo posto, lo scaffale avanzava e il secondo libro veniva spinto fuori; e così via, essendo la giornata divisa secondo le ore di lezione e le ore di studio richieste da ogni disciplina».
In questa genialità meccanica Muir è figlio dei tempi: pullulano gli inventori e le invenzioni, utili e inutili. È arrivato in America su una nave a vela, ma da Pardeeville a Madison viaggia in treno: quale testa geniale dell’epoca non ha inventato almeno una macchina? Ma la passione per le possibilità della tecnica cederà ben presto alla passione per i meccanismi della Natura. «Inventai anche una macchina per rendere visibile la crescita delle piante e l’azione della luce del sole, un aggeggio molto delicato, chiuso dentro una scatola di vetro». Dalla meccanica alle scienze naturali il passo non è poi così lungo: che cos’è l’universo, infatti, se non un sublime, grandioso, perfetto meccanismo? Il caso non è ancora entrato nella scienza: tutto nella natura ha un ordine e un senso, tutto si muove e interagisce secondo un disegno e un’intenzione, dalla più piccola goccia d’acqua al più grande sconvolgimento tellurico. Anni dopo, davanti alle meraviglie di Yosemite, Muir troverà infinite corrispondenze: tra il minimo e l’immenso, tra le forme delle nuvole e quelle delle montagne, tra la struttura dei gigli e le sagome degli abeti…
Quando è chiaro che il luogo dell’apprendimento vero non è l’università, ma la natura, Muir è pronto a mutar vita. «Lungi dall’essere soddisfatto di ciò che avevo imparato [all’università] … partii per una grandiosa escursione botanica e geologica – che durò cinquant’anni e dura tuttora», scrive nel 1913, un anno prima della morte, «sempre lieto e libero, povero e ricco, senza minimamente darmi pensiero di procurarmi una laurea o di farmi un nome… Lasciavo l’università del Wisconsin per l’università della Wilderness». Nella sostanza, l’immagine che qui Muir traccia di sé corrisponde al vero: la confermano le scelte di tutta una vita. L’occasione contingente che lo allontana dall’università però è taciuta: nel 1861 scoppia la Guerra Civile, nella primavera del 1863 il Congresso approva una proposta di leva obbligatoria per tutti i maschi tra i venti e i quarantacinque anni, suscitando un putiferio. Accanto alle moltitudini pronte a partire, c’è chi rifiuta di combattere per questioni di principio, chi contesta la politica dell’Unione, chi non apprezza l’idea di abolire la schiavitù. Molti immigrati recenti, soprattutto negli stati interni, come il Wisconsin, non vogliono rischiare la propria vita e le proprie fortune in una guerra che sentono estranea: è l’Est ricco, forte, industrializzato cui importa combattere. A migliaia si sottraggono alla leva. Muir va in Canada. Tornerà a guerra finita. Nel frattempo comincia i suoi studi di botanica e geologia sul campo.
Le piste dell’Ovest
Quando giunge in California, Muir ha trent’anni. Ha attraversato a piedi gli stati orientali, dal Kentucky alla Florida, seguendo «l’itinerario più selvaggio, più boscoso e meno battuto», ma il sogno di gioventù – esplorare il Sud America sulla scia di von Humboldt – è naufragato sulle coste di Cuba, dove la febbre lo divora e nessuna nave lo imbarca. La California diventa l’alternativa – “fortunata”, dirà poi – all’impossibile. Imbarcarsi a New York per Aspinwall, il porto della costa panamense che si apre sul Golfo del Messico, è facile e costa poco; l’istmo è percorso da una ferrovia, dall’altra parte altre navi fanno la spola con San Francisco. Ad Aspinwall un cimitero accoglie i viaggiatori che soccombono alle fatiche del viaggio e alle febbri. Sono pochi rispetto a quelli che si perdono sulle piste dell’Ovest: la ferrovia che collega le due sponde del continente non è ancora terminata, la via più breve e più sicura per la California è ancora quella di Panama. San Francisco non lo impressiona: è una città, ne ha viste tante. Appena sbarcato chiede a un passante la via più breve per uscire dall’abitato. Per andare dove? «Un posto qualunque, purché sia selvaggio». In verità Muir ha in mente una meta. Intorno alla fine degli anni Cinquanta si è cominciato a parlare della favolosa Yosemite Valley, la cui “scoperta”, da parte dei bianchi, risale al 1851. Gli indiani naturalmente la conoscono da sempre; nella valle si è rifugiato un gruppo di ribelli Ahwahneechee, una delle tribù del versante occidentale della Sierra che il Governo sta tentando di confinare nelle riserve.
Il luogo è diventato subito famoso grazie ai racconti dei primi soldati che vi sono giunti per stanare le bande del capo Tenaya: stupende cascate, pareti di granito, torrenti di acque chiare, verdissimi prati, boschi. Pochi anni dopo la scoperta, arrivano i primi viaggiatori, qualche vedutista, i primi fotografi. Nel 1864, dietro le insistenze di Frederick Law Olmsted, architetto del Central Park di New York, Lincoln e il Congresso creano il Yosemite Grant, che comprende due aree, la valle di Yosemite e la foresta di sequoie di Mariposa Grove, e ne affidano la gestione allo Stato di California «sotto l’esplicita condizione che tali aree siano conservate per usi pubblici, per svago e ricreazione e che siano mantenute inalienabili per tutti i tempi». Muir dunque visita Yosemite nel 1868, quando la valle è già riserva. L’estate seguente torna a percorrere la Sierra, si spinge fino al lago Mono, dall’altra parte della catena, percorre in lungo e in largo gli alti bacini del Merced e del Toulomne. Da quel momento fa della valle la sua casa: vi resterà quasi ininterrottamente fino al 1875. Per campare ha bisogno di poco: è abituato a sopravvivere per giorni a pane e acqua, a dormire all’addiaccio, a non temere il freddo e la pioggia. Il suo bagaglio consiste in qualche indumento, una pressa per i fiori, il taccuino per appunti e schizzi, una coperta, un sacchetto di tè. In un primo momento fa il pastore, poi il boscaiolo, ma taglia solo gli alberi che cadono da sé. Pascoli e foreste sono, con le miniere, le due attività di maggior sfruttamento della Sierra: contro allevatori e industriali del legno si combatteranno in futuro le maggior battaglie per la difesa del parco, costantemente minacciato dalle speculazioni. Muir visita ogni angolo remoto della Sierra, studia il movimento dei ghiacciai e la formazione delle montagne, la vita di piante e animali; nel frattempo osserva l’impatto dell’uomo bianco sull’ambiente. «Che parte ha l’uomo nel destino delle montagne?», si chiede.
La risposta è, per l’epoca, rivoluzionaria: «La Natura può aver destinato la terra fertile ad altri scopi che al nutrimento degli esseri umani». Nel 1871 Muir comincia a pubblicare i risultati dei suoi studi: le sue teorie sull’origine glaciale della valle di Yosemite, che contrastano con quelle allora accolte, susciteranno la derisione dei più eminenti studiosi dell’epoca, ma alla lunga si riveleranno esatte. Negli ambienti intellettuali si diffonde la fama di questo eccentrico personaggio che vive in una capanna nei boschi e i visitatori della valle vogliono conoscerlo. Un giorno compare Ralph Waldo Emerson, il filosofo americano sulle cui opere si è formata tutta la generazione di Muir. Muir lo porta ad ammirare le sequoie di Mariposa Grove ma, con suo disappunto, non riesce a convincerlo a bivaccare sotto le stelle. In compenso, Emerson è così colpito da Muir, da aggiungere il suo nome alla breve lista delle persone veramente notevoli incontrate in vita sua. Compare anche Thérèse Yelverton, scrittrice in cerca di ispirazione. Resta nella valle tutta l’estate; quando torna a San Francisco scrive Zanita, un romanzo ambientato a Yosemite in cui uno dei protagonisti, Kenmuir, è un Muir idealizzato e alquanto romantico.
Gli “Studies in the Sierra”, pubblicati sull’Overland Monthly e destinati non agli studiosi ma a un più vasto pubblico, contribuiscono non poco alla fama di Muir. Da avamposto di frontiera San Francisco si è trasformata in una città che intende rivaleggiare con le metropoli della costa atlantica, alle quali è finalmente collegata dalla ferrovia transcontinentale; una città in fermento, dove agli avventurieri d’ogni sorta si mescola una intellettualità giovane, costituita da artisti, professori universitari, esponenti delle professioni liberali, tra cui gli scritti di Muir cominciano a fare proseliti: la frontiera è finita, lo sfruttamento incondizionato delle risorse deve essere limitato e regolamentato, le foreste vanno sottratte alla distruzione. Accanto a chi, giunto in California per fare fortuna, intende solo le ragioni del profitto e del denaro, si fa via via più forte la voce di chi investe sul futuro dello stato. Da questi ambienti usciranno i futuri soci del Sierra Club, fondato da Muir e altri nel 1892 e tuttora una delle istituzioni americane più attive nell’ambito della tutela dell’ambiente.
Dal 1875 Muir comincia a trascorrere gli inverni a San Francisco. Passa per uno stravagante, ma ha molti amici che apprezzano la sua lucida intelligenza e intuiscono la forza e l’originalità della sua concezione della natura. Per Muir il rapporto con la natura non si esaurisce né con la visione dell’artista o del mistico, né con l’osservazione dello scienziato: è necessaria l’esperienza fisica. All’inizio è un istinto: quello che lo induce a salire su un albero durante un temporale, a scalare una montagna nella bufera, a desiderare di essere sulla Sierra in pieno inverno per vedere le valanghe precipitare dai monti e la neve piegare a terra intere foreste. In seguito è matura riflessione: la coscienza che la civiltà non può prescindere dalla wilderness, che la natura selvaggia è per l’uomo, soprattutto l’uomo cittadino, fonte di rigenerazione e conoscenza di sé. Muir però non è un intellettuale: anni dopo, quando gli amici lo convinceranno a mettere la sua esperienza e la sua penna al servizio di una causa, si lamenterà della fatica che ogni libro gli costa. Tutte le estati Muir torna sulla Sierra o viaggia per altre montagne. Nel 1879 visita l’Alaska, che gli Stati Uniti hanno di recente acquistato dalla Russia: vi tornerà altre quattro volte, affascinato dall’universo di ghiacci e d’acqua dell’arcipelago Alessandro. Sono veri viaggi di esplorazione: pochi bianchi sono arrivati lassù, per lo più cercatori d’oro che passano e a volte scompaiono senza lasciare traccia. Muir e un amico missionario arrivano fino a Glacier Bay, esplorano in canoa i fiordi che si aprono sulla baia, scoprono nuovi ghiacciai. Muir contempla le grandi forze della natura all’opera. Quando scala una montagna nel pieno di una bufera di neve, uno degli indiani che gli fanno da guida commenta: «Dev’essere uno stregone per andare a cercare la conoscenza in un luogo del genere… e in un tempo così orribile». Ma per Muir la wilderness non è mai minacciosa: la paura nei confronti della natura non esiste. C’è solo incondizionata ammirazione e umiltà: la coscienza che l’uomo non è il centro dell’universo, che tutto nella natura ha un ordine e un fine, e che questi includono, ma non privilegiano, l’umanità.
Qualunque idiota può distruggere gli alberi
Nel 1889 Robert Underwood Johnson, direttore del newyorkese Century Magazine, che ha già pubblicato parecchi articoli di Muir, giunge in California per cercare nuovo materiale per il giornale. L’Ovest e la natura selvaggia “tirano” bene all’Est e Johnson ha in mente un progetto ambizioso: iniziare una campagna stampa che induca il Congresso a creare un grande parco nazionale attorno alle due riserve di Yosemite e di Mariposa Grove, istituite fin dal 1864. Naturalmente va a trovare Muir, che nel 1880 si è sposato e da allora vive a Martinez, nei dintorni di San Francisco, occupandosi dei rigogliosi frutteti del suocero. La sua permanenza sulle montagne si è ridotta a poche settimane all’anno, ma la vita del coltivatore non gli giova: quando si ammala è costretto a tornare sulla Sierra per ritrovare la salute. Johnson arriva al momento giusto. Muir ha constatato da tempo la disastrosa gestione delle aree protette da parte dello stato di California. Soggetti alle pressioni di forti interessi, i politici locali non hanno la forza, né la volontà, di imporsi. Sarebbe opportuno che le riserve passassero sotto la tutela dello stato federale, pensa Muir – al solito molto in anticipo sui tempi. Visitando Yosemite insieme, Johnson e Muir mettono a punto il piano: Muir scriverà qualche articolo, Johnson userà la sua influenza politica a Washington. La prima vittoria è presto ottenuta.
L’anno seguente, 1890, viene istituito il Yosemite National Park, che include i bacini superiori del Merced e del Toulomne; nello stesso anno nascono altri due parchi più piccoli nella Sierra meridionale, a protezione dei boschi di sequoie. Da quel momento in avanti Muir dedica tutte le sue energie alla causa della tutela della wilderness. «Un’azienda agricola che richieda e pretenda il sacrificio di una nobile vita, o di un nobile impegno, dovrebbe essere gettata al vento…», decide la moglie, dispensandolo dagli impegni dell’azienda di famiglia. In breve Muir diventa un’autorità: gran parte dei parchi nazionali creati in quegli anni negli stati dell’Ovest devono la loro esistenza al suo impegno e alla sua penna. Quando i politici minacciano le riserve forestali create dal Congresso per consiglio della Forestry Commission, di cui lui pure fa parte, Muir suscita l’indignazione dell’opinione pubblica con un articolo sull’Atlantic Monthly che proclama: «Qualunque idiota può distruggere gli alberi. Essi non possono fuggire; e se anche potessero, sarebbero distrutti lo stesso: inseguiti e abbattuti fin tanto che dalla loro pelle di corteccia, dai palchi dei loro rami, dal loro magnifico dorso di legno sia possibile trarre un briciolo di divertimento o un solo dollaro…». A partire dal 1894 Muir comincia a pubblicare libri, che in parte raccolgono articoli precedenti, in parte rielaborano gli appunti dei quaderni di viaggio. Nel frattempo, sulla scia di simili istituzioni che da una decina d’anni fioriscono all’Est, nasce a San Francisco il Sierra Club, allo scopo di «esplorare, godere e rendere accessibili le regioni montuose lungo la costa del Pacifico; pubblicare materiale attendibile su dette zone; trovare il sostegno e la cooperazione dell’opinione pubblica e del governo per la conservazione delle foreste e delle altre attrattive naturali delle montagne della Sierra Nevada». Muir è eletto presidente e conserva la carica fino alla morte.
Nello statuto del Club, intenti scientifici, ricreativi e didattici si mescolano: non è ancora chiaro che cosa debba intendersi per “conservazione”, né quale sia il suo scopo. È chiaro però che sulla destinazione e l’uso delle aree protette vi sono contrasti: per alcuni conservazione è l’opposto di sfruttamento, per altri è l’opposto di sfruttamento indiscriminato – e dunque significa sfruttamento controllato delle risorse. Appena si rende conto del problema, Muir cerca di spostare i termini della questione: «Migliaia di cittadini stanchi, stressati, supercivilizzati stanno cominciando a scoprire che andare sulle montagne significa andare a casa; che la natura selvaggia è una necessità; e che parchi e riserve sono utili non solo come sorgenti di legno e di fiumi irrigui, ma come sorgenti di vita». Così comincia l’appassionata difesa dei parchi nazionali in Our National Parks. Da questo momento in avanti è chiaro che Muir si rivolge non tanto ai cittadini della California, dei quali comincia a diffidare, ma ai cittadini di tutta l’Unione, in particolare agli uomini e alle donne dell’Est, che nelle metropoli industrializzate e sovraffollate possono recepire il discorso della conservazione della wilderness assai più che non gli agricoltori dell’Ovest, per i quali quella medesima wilderness è appetibile fonte di ricchezza. Ma perché l’opinione pubblica dell’Est porga orecchio agli appelli, è necessario trovare argomenti convincenti.
È per questo motivo che intorno alla fine del secolo gli scritti di Muir cominciano a presentare il turismo come una sorta di antidoto ai «vizi di una esagerata industrializzazione». Rispetto alla radicale intuizione giovanile che la natura non è stata creata a uso e consumo dell’uomo, le posizioni di Muir negli ultimi anni rappresentano un compromesso: pragmaticamente Muir riconosce che l’America di fine Ottocento non è disposta a rinunciare a risorse trasformabili in dollari se non per trarne qualcosa di altrettanto utile in cambio. Dilaga, soprattutto all’Est, la nozione di wilderness come terreno di gioco, della natura come luogo della sana ricreazione del cittadino urbanizzato. Con i Club alpini si moltiplicano le associazioni di attività outdoor. Lo stesso Sierra Club comincia a organizzare campeggi sulla Sierra per i soci. Nel 1903 il presidente Roosevelt visita Yosemite. Ha chiesto che sia Muir a fargli da guida e per quattro giorni, snobbando i festeggiamenti ufficiali, lo segue per i sentieri del parco e bivacca con lui sotto le stelle: ci sono molte cose che il presidente desidera discutere con l’uomo che al momento è la massima autorità sul fronte della tutela del territorio. Muir senza dubbio approfitta dell’occasione per insistere sulla necessità che la valle di Yosemite venga sottratta alla gestione locale e inserita nel parco nazionale che la circonda; il presidente può constatare di persona in che stato è ridotta la valle: fuochi d’artificio, spettacoli di luci sulle pareti, vie ferrate… L’altra questione che Muir pone a Roosevelt è quella della valle di Hetch Hetchy, una seconda Yosemite che si apre lungo il corso del Toulomne.

Hetch Hetchy si trova dentro i confini del parco, ma i politici di San Francisco propongono di costruirvi una diga che la trasformi nell’immensa riserva d’acqua di cui la città ha bisogno. La cronica scarsità d’acqua è una delle ragioni per cui tanto devastanti sono gli incendi che periodicamente dilagano tra i suoi edifici in legno e la soluzione di Hetch Hetchy è allo studio da un paio d’anni. Si è appena agli inizi di una questione che scalderà il dibattito politico a lungo e sulla quale anche il Sierra Club finirà per spaccarsi.
Le due grandi battaglie contro lo stato di California crearono a Muir molti nemici. La prima fu vinta: nel 1906 la valle di Yosemite tornò alla gestione del governo federale. La seconda fu una clamorosa sconfitta: nel 1913, sotto l’amministrazione del presidente Wilson, il Congresso accolse la proposta di San Francisco di sbarrare il corso del Toulomne con una diga a Hetch Hetchy.
Muir morì l’anno seguente, 1914. Due parole aveva sempre usato per parlare di sé: tramp, vagabondo e mountaineer, uomo di montagna.
Tramp include sempre, nell’immaginario americano, un percorrere spazi immensi: è l’anima del pioniere rimasta impigliata dentro il linguaggio. Mountaineer erano per lui anche gli alberi, le piante, gli animali che popolano le solitudini montane. Per riassumere il senso della sua vita scrisse: «Ero uscito solo per fare una passeggiata ma alla fine decisi di restar fuori fino al tramonto perché mi resi conto che l’andar fuori era, in verità, un andar dentro».
Note bibliografiche
Michael P. Cohen, The History of the Sierra Club, 1892-1970, San Francisco, 1988;
Tom Turner, Sierra Club -100 Years of Protecting Nature, New York 1991;
David Robertson, West of Eden: A History ofthe Art and Literature of Yosemite, 1984.
















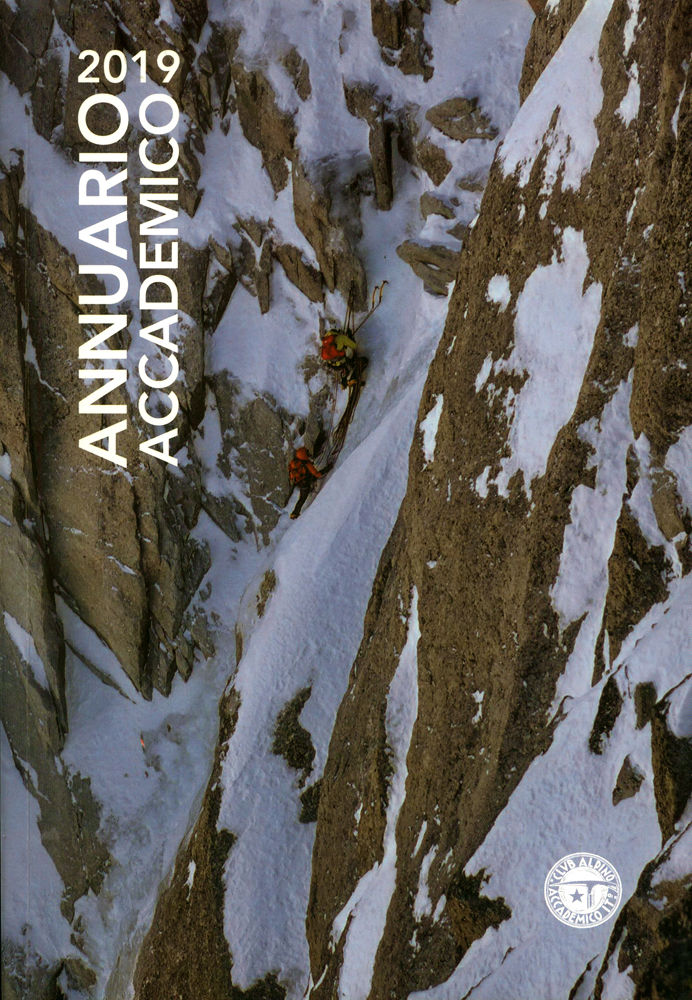

Lascia che la pace della natura entri in te come i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi. Lascia che i venti ti soffino dentro la loro freschezza e che i temporali ti carichino della loro energia. Allora le tue preoccupazioni cadranno come foglie d’autunno.
J. M.
Jim Morrison😉?
No, John Muir.
Si iii Alberto la mia era gratuita provocazione!data solo dalle iniziali identiche.